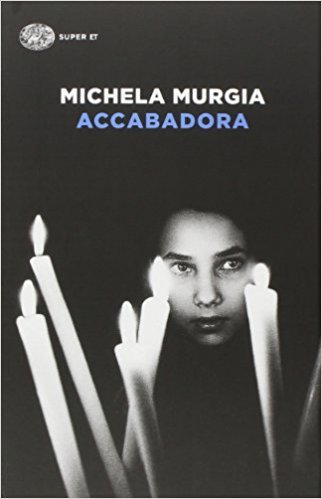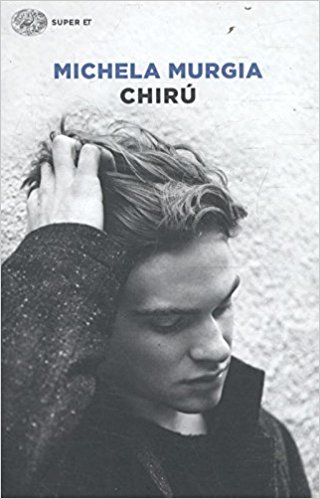Schiettezza e autoironia sono doti che Michela Murgia non lesina. Soprattutto quando parla della sua visione della scrittura e del rapporto con il suo lavoro. “Per certi versi quando sto male, scrivo. Quindi, il fatto che io scriva un libro ogni sette anni è una buona notizia per la mia vita”.
Come si legano vita e scrittura?
Tra di loro c’è un’enorme differenza. Tre quarti delle cose interessanti che accadono nella vita, nella scrittura non lo sono così tanto, a meno che non intervenga un elemento di metodo che rende quella verità pratica una verità letteraria, di più sofisticata natura. Quando si dice “una scrittura autentica”, si fa un’affermazione ossimorica. La scrittura è autentica nella misura in cui è più finzionale. Per ottenere una verità letteraria bisogna prendere una cosa vera e trasformarla, torcerla completamente fino a restituirla a una realtà che può stare sulla pagina, che non è quella della vita.
Il rapporto tra vita e scrittura è un rapporto di tradimento, anche di violenza. La scrittura deve entrare nella vita come un bisturi.
Lo scrittore ha la responsabilità di mettere a fuoco il dato reale che vuole restituire al lettore e ha la libertà di restituirlo anche in modo ipertrofico, se vuole. Anche se si tratta di mettere a fuoco un chiodo in una stanza. Serve, però, che lo faccia in una maniera detonante.
Come si ottiene questo effetto deflagrante?
Con una lingua potente, povera di aggettivi e priva di avverbi. A un libro si chiede di più di quello che si può dire parlando. Si chiede una scrittura ragionata, ottenuta con ore di cesello.
La letteratura è sempre un’operazione di cesello che restituisce un mondo più tridimensionale rispetto a quello in cui viviamo. È questo che il lettore cerca: un mondo più ampio.
Un mondo che contrasti l’analfabetismo funzionale, ad esempio.
L’incapacità di comprendere qualcosa che superi l’esperienza diretta del singolo è un problema da non sottovalutare. È un fenomeno che riguarda in larga misura i lettori anglosassoni. Sono abituati a leggere prevalentemente libri scritti nella loro lingua originale e poi tradotti in tutto il mondo, che sempre si confronta con la letteratura inglese.Ma il lettore inglese si rapporta poco con la letteratura straniera. Leggono molto di meno libri tradotti da altre lingue e quando questo accade è perché l’editor ha messo mano pesantemente al romanzo per avvicinarlo al lettore e farlo restare nella sua zona di comfort. Altrimenti sceglie dell’altro.
Sempre più spesso si sente parlare della differenza tra scrittori di trama e di lingua: cosa ne pensa?
Si dice anche che gli scrittori di trama siano dei grandi inventori di storie. Ma gli scrittori di trama, che io invidio e ammiro tantissimo, sono dei meccanici: sono in grado di mettere in sequenza dei fatti che sono già avvenuti mille volte. Ma lo fanno in una maniera sorprendente per chi li legge.
Le storie archetipiche da raccontare sono cinque, sei al massimo: due vogliono stare assieme e non ci riescono, uno vuole tornare a casa e qualcuno glielo impedisce, qualcosa si perde e nessuno la trova.
Poi vengono declinate in migliaia di varianti, ma la materia prima è sempre quella e la bravura di uno scrittore consiste nella capacità di regalare uno sguardo nuovo a una storia vecchia. Se si vuole scrivere un best-seller, non serve andare alla ricerca di storie nuove: il bambino che c’è in ogni lettore in realtà vuole sentire la stessa fiaba raccontata con le stesse parole, come quando era piccolo.
Può fare qualche esempio?
Pensiamo a chi costruisce narrazioni per altri sistemi di rappresentazione: gli sceneggiatori cinematografici. Hanno bisogno di essere efficaci commercialmente e non sono interessati all’originalità a tutti i costi. “Prendete Harry Potter e il calice di fuoco” e “Star Warsl’impero colpisce ancora”. L’archetipo è lo stesso: c’è un bambino che ha perso i genitori per ragioni misteriose e viene allevato dagli zii in un contesto periferico. A un certo punto arriva un messaggero esterno, gli rivela cheha doti speciali e un grande destino e lo porta via con sé. Un bambino diventerà Jedi, l’altro mago. Poi intervengono altri maestri superiori e due personaggi d’aiuto, un ostacolo, una sfida/nemico da vincere e un finale aperto che presuppone un seguito. La trama è identica e mi sono chiesta quanti genitori che hanno accompagnato i propri figli a vedere il film di Harry Potter si sono resi conto che hanno visto una narrazione uguale a quella vista quand’erano ragazzini loro.
Con il fantasy la Rowling ha fatto una fortuna.
Tutta la letteratura è fantasy.Anche quando si scrive un romanzo interamente costruito sulla figura della propria madre rappresentata con lo stesso nome, carattere, corporatura si sta scrivendo dell’idea che si ha della propria madre.
Lo scopo della narrazione non è quello di ingannare il lettore, ma quello di farlo arrivare ad una realtà più profonda. Importante, allora, diventa il rampino, il livello di aggancio che si riesce a stabilire con il lettore.
Se tutta la letteratura è “fantasy”, ha senso parlare di letteratura di genere?
In Italia esiste una distinzione editoriale stupida tra letteratura alta e letteratura di genere, presupponendo che tutto quello che devia dal realismo o metta in scena dei meccanismi riconoscibili come quelli del giallo sia genere. In realtà, tutti gli elementi di una trama hanno lo scopo di restituire un’autenticità di esperienza. Ci sono studi di neurobiologia che hanno dimostrato che l’esperienza forte rivelatoria della lettura lascia le stesse tracce dell’esperienza reale. Leggere libri che ci coinvolgono, che ci toccano, lascia nella memoria gli stessi ricordi delle esperienze vissute. Questo produce un abisso di responsabilità sia per chi legge sia per chi regala libri, soprattutto ai bambini. Gli state regalando un immaginario di ricordi potentissimo. Io, ad esempio, sono sicurissima di aver abitato nella via Pal e il primo lutto della mia vita è stata la morte di Nemecsek. Quando mia madre mi chiese il motivo del pianto, mi sentii rispondere che non era una morte vera, trattandosi di un libro.
Fu allora che capii che esistono due tipi di persone: quelle per cui i libri sono veri e quelle per cui non lo sono. Tuttora, pur sapendo che scrivo libri, mia madre è ancora convinta che non abbia un lavoro, che non faccia niente.
E parlare di scrittura sarda ha senso?
Essere scrittori sardi vuol dire delle cose che non sempre mi piacciono. Ad esempio ci si aspetta che uno scrittore sardo sia portatore di un’alterità che da uno scrittore romano, ad esempio, non ci si attende. Ciò genera una serie di equivoci che in qualche caso è opportuno scardinare. Si tratta di educazione del lettore: rompere l’idea che quello che racconti appartenga a un ambito. Mi spiego: non faccio corsi di scrittura, faccio corsi di narrazione orale, soprattutto per persone anziane. Per rivelare loro che hanno un sapere che non stanno usando. Parto chiedendo se credono che esista un romanzo sardo e la risposta è sempre affermativa. Non sanno di preciso elencare i tratti salienti che lo contraddistinguono, ma affermano di saperlo riconoscere se lo incontrano. Allora leggo due pagine senza rivelare titolo e autore. È una storia di ambientazione agro-pastorale, montana, con due personaggi maschili che si chiamano Pedro e Zicco che stanno insieme, fanno una vita da allevatori e sviluppano un’amicizia in un luogo che si chiama “Monti des’ischinasegada”, la montagna della schiena rotta. Poi chiedo di identificare l’autore. Partono con Grazia Deledda, passano a Satta, Gavino, Ledda, Niffoi, Fois e persino me. La loro sorpresa quando rivelo che le due pagine che ho letto sono l’incipit de “I segreti di Brokeback mountain” è enorme. Cambiando solo i nomi dei due personaggi e del luogo, tutto quello che sembrava piccolo, campagnolo, contingente, improvvisamente diventa il Wyoming, l’epopea western americana con tanto di storia tra due omossessuali.
Questo è l’esempio di quanto ci sia difficile scoprire le storie grandi, l’epica, nelle storie piccole, quelle di casa. La letteratura azzera le distanze fisiche, quelle culturali.
Esiste una narrazione italiana?
L’Italia è un Paese senza trama, senza un immaginario comune, condiviso. Non ha grandi narrazioni che la attraversino per intero. Non esiste un romanzo popolare italiano, che abbia raccontato veramente il Paese. Ci sono tante realtà parcellizzate e ciò fa sì che raccontiamo solo piccole storie che possono essere capite dentro la cornice stessa che le ha generate.
Non esiste un romanzo popolare, ma esistono diversi premi che vanno tenuti in vita per tutta la durata dell’anno. Quali, a suo avviso, le strategie migliori?
L’unico modo passa per le scuole e il Premio Comisso lo sta già facendo. Non esiste una flessione del bisogno di narrazione anche se esiste una flessione della pratica della lettura. Stimolare i ragazzi dei licei, anche i più giovani, a scrivere, a raccontare le storie, a dare la propria voce alla visione del mondo è un modo per continuare a trasmettere l’idea che la civiltà e la narrazione vanno di pari passo. Quindi io sono per un forte investimento sulle scuole. Non vedo modo migliore per allargare la base sociale dei lettori. Pensare di convincere una persona adulta a iniziare a leggere è pura utopia.
Invece per gli scrittori cosa significano i premi letterari?
Innanzitutto sono un riconoscimento al lavoro. Qualche volta sono un aiuto economico che consente di continuare a scrivere. La scrittura è un “hobby” molto faticoso e poter usufruire di premi in denaro è un aiuto molto importante che permette di prendersi il tempo necessario per chiudere un’opera. In Italia purtroppo c’è una scarsa abitudine alla residenza letteraria e l’investimento pubblico è modesto. Nei Paesi europei esistono borse artistiche.Servono a persone di tutte le età per andare un mese o due ospiti di una comunità a mezza pensione per terminare il lavoro. Quindi manterrei il premio in denaro o, al limite, lo sostituirei con la possibilità di vincere una residenza letteraria. A me è capitato di fare esperienze del genere in torri campanarie in Toscana. Situazioni molto spartane: un letto, una connessione internet e una ribollita la sera. In cambio fai un incontro con la biblioteca locale, incontri i lettori del posto, citi nel libro la comunità che ti ha ospitato. Non riesco a terminare un romanzo se rimango a casa tra parenti e amici. Ho bisogno di cambiare aria e la residenza letteraria è il giusto compromesso per trovare la concentrazione senza dovermi isolare dal mondo.
Differenze tra giurie e criteri per assegnare i premi. Quale la formula migliore?
Dipende dal tipo di riconoscimento che lo scrittore va cercando. Se vuole piacere ai colleghi, lo Strega diventa essenziale.È un premio che non viene conferito dai lettori, ma dai pari. È un riconoscimento elitario di appartenenza alla comunità letteraria. È un gioco di società: ci sono influenze editoriali e considerazioni che spesso non hanno a che fare con il libro in concorso. Io, ad esempio, non vi partecipo e non ho nemmeno il voto. I premi letterari sono quelli dove esiste una giuria popolare o di qualità che vota davvero il libro. Penso al Mondello: partecipano al voto anche gli studenti di dieci licei di Palermo. Vincerlo sapendo che ti hanno votato trecento studenti è una grande soddisfazione. La soluzione migliore è quella che prevede una prima selezione ad opera della giuria dei letterati e la votazione finale affidata ad una giuria popolare che cambia ogni anno. Mi sembra la formula più rispettosa della verità del libro che prima ha convinto una giuria qualificata e poi convince il lettore comune che rappresenta demoscopicamente il Paese. Il libro passa attraverso il filtro di qualità iniziale e il filtro di popolarità in uscita. Sono molto fiera di avere vinto il Campiello nel 2010.