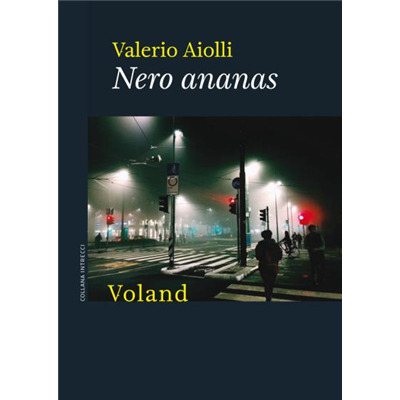12 dicembre 1969 – 17 maggio 1973. È tra queste due date che Valerio Aiolli dipana la sua trama, tentativo di immersione in quel «buco nero» della nostra storia che inizia «un secondo dopo il botto» di Piazza Fontana. Sulla scena, in costante bilico tra la dimensione pubblica e privata, si alternato neofascisti e politici (im)pavidi, elementi dei servizi segreti e pseudo anarchici. Nel mezzo, la storia di un bambino che vede sparire la sorella il giorno stesso della bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura…
Nell’ambito dell’ormai consolidata riscoperta degli anni di piombo come tema letterario, il suo romanzo si colloca in una posizione leggermente sfalsata; di contro alla generale suggestione esercitata dalla lotta armata di sinistra, lei sceglie di affrontare l’inizio della stagione della violenza concentrando la narrazione tra il 1969 e il 1973, gli anni di avvio e consolidamento della “strategia della tensione”. Cosa l’ha spinta a tale decisione?
In parte, in piccola parte, la risposta è contenuta nella domanda: ho scelto quel periodo proprio perché era un terreno meno battuto rispetto agli anni successivi, i veri e propri “anni di piombo”, che fin da quasi subito avevano prodotto una narrazione, diretta o mediata, piuttosto corposa. Ma il motivo primario della mia scelta sta più a monte. È un motivo personale che si salda con una riflessione storica. Credo che ogni generazione abbia il suo “giorno della fine dell’incanto”.
Per la generazione dei miei nonni fu la devastazione della Seconda guerra mondiale che squagliò la grandeur di cartapesta del regime fascista. Per quella dei miei genitori forse fu l’uccisione di JFK, Per quella dei miei figli potrebbe essere l’11 settembre.
Io, quando esplose la bomba di piazza Fontana, avevo otto anni. Troppo pochi per dire che ne fui direttamente segnato. Ma l’effetto di quel botto lo percepii potentemente comunque. Avvertii, attraverso le facce dei parenti, i loro commenti, i titoli dei giornali che giravano per casa, che qualcosa di inaudito era accaduto. Che una pagina di storia si era voltata.Più tardi mi sono convinto che quello fu davvero un momento di passaggio nella nostra storia recente.
C’è un prima e un dopo piazza Fontana. Quell’evento ha dato luogo a reazioni e controreazioni che si sono propagate per anni, per decenni.
In più, essendo rimasto, almeno dal punto di vista giudiziario, mai chiarito fino in fondo, ha generato un effetto-nebbia, come se la nuvola di fumo di quell’esplosione non si fosse mai diradata del tutto. Proprio questa indeterminatezza ha contribuito a formare in me il desiderio, direi quasi la necessità, di immergermi con gli strumenti della letteratura in quegli anni così particolari. La spinta definitiva me la diedero poi le inchieste e i processi dei primi anni Duemila, che per la prima volta portarono alla luce nei dettagli il mondo degli ordinovisti veneti, i loro contatti con i servizi, le loro pratiche neofasciste e i loro sogni deviati.
Nei segmenti narrativi dedicati agli stragisti di destra, la cronaca dei fatti nasconde il tentativo di far emergere le loro ansie e contraddizioni. Stessa cosa per quanto riguarda il Pio, i cui sentimenti sono passati quasi al microscopio con grande capacità evocativa. Quanto è stato difficile calarsi “al fondo” di tali personaggi?
In effetti questo è stato uno dei punti fondamentali, e una delle difficoltà maggiori, della stesura. Io volevo raccontare uomini, non “terroristi”. Uomini, non “politici”. Uomini, non “anarchici”. Volevo, sì, che fossero uomini che avessero scelto (istintivamente o meditativamente) di fare i terroristi, i politici, gli anarchici.
Ma volevo restituire i chiaroscuri, le contraddizioni, le certezze irrazionali, le sorprendenti insicurezze che stanno dentro gli esseri umani.
Volevo che gli eventi scaturissero in maniera naturale dal flusso di energia, dai pensieri e dalle decisioni intime di questi uomini. Come mi pare che accada nella vita.
Siccome questi uomini, questi personaggi, sono tanti, e di natura molto diversa l’uno dall’altro, ho dovuto trovare per ognuno di loro una voce che li raccontasse al meglio, che fosse distinguibile dalle altre voci ma che allo stesso tempo non sbilanciasse più di tanto, stilisticamente, un romanzo che già nella concezione e nella struttura era parecchio complesso.
Poi, una volta trovata la voce, c’era da calarsi giù, nel cunicolo di ogni singola personalità, e, capitolo dopo capitolo, arrivare sempre più in fondo, nel buio, per approfondire il personaggio via via che la storia procedeva.
Alla fine di ogni capitolo tornavo in superficie un po’ spossato, e mi ci voleva del tempo prima di ritrovare la voce del personaggio protagonista del capitolo successivo, e per trovare l’energia di immergermi nel nuovo cunicolo. Anche per questo il libro mi ha preso molti anni per la stesura (interrotta varie volte per finire altri romanzi apparsi nel frattempo). Scrivere il personaggio del Pio, nel complesso, mi è comunque piaciuto molto. Poter ripercorrere dall’interno una vicenda politica abbastanza esemplare del dopoguerra italiano, mostrare il lato privato, intimo, del potere democristiano, quello di cui di solito non si parla, che quasi nemmeno si immagina: è stato, anche per me, un viaggio di scoperta all’interno di una dimensione umana che finora mi era sfuggita.
Calimero e la sua vicenda rappresentano un ponte tra la grande Storia e il riflesso di questa nella vita quotidiana. Il suo cammino di lacerazione e crescita può considerarsi rappresentativo di quella “perdita dell’innocenza” segnata dalla bomba di Piazza Fontana?
In qualche misura forse sì, anche se non in modo rigido. La cosa particolare è che il libro era nato senza Calimero e la sua famiglia. Oggi mi sembra impossibile, la maggior parte dei lettori si è affezionata al libro attraverso la simpatia e l’affetto per Calimero, ma io ho scritto credo il primo centinaio di pagine del romanzo convinto che i miei personaggi sarebbero stati soltanto i neofascisti, l’anarchico, il politico, gli esponenti dei servizi. Poi, a un certo punto, mi sono accorto che mancava qualcosa.
Mancava al libro, e mancava a me. Mancava un punto di vista altro, normale, che facesse da contraltare alle vite estreme dei ragazzotti (a volte un po’ cresciuti) neofascisti, a quella border line dell’anarchico, a quella umilmente ambiziosa del politico. Mancava una voce che passasse durante il racconto dall’ingenuità a un inizio di consapevolezza, cosa che accade a tutti tra infanzia e adolescenza, e che accadde all’opinione pubblica italiana proprio in quegli anni, quando improvvisamente il mondo rappresentato da Carosello, vissuto fin lì in modo abbastanza acritico, cominciò a creparsi, mentre a poco a poco si facevano strada consapevolezze sempre meno rassicuranti su cosa stava accadendo nell’ombra, e la società si polarizzava e diventava ogni giorno più violenta. Inoltre,al romanzo mancava una storia d’amore. Quale è, a suo modo, quella tra Calimero e sua sorella, il personaggio-assente, chiave di volta dell’architettura del libro.
Calimero e la sua famiglia hanno portato solidità e allo stesso tempo aria al racconto, anche alla parte “sotto la linea dell’orizzonte”, che di quell’aria aveva particolarmente bisogno.
L’attenzione al linguaggio, tratto costante della sua produzione, è particolarmente accentuata in Nero ananas. Sembra che lei voglia ri-costruire un codice identitario, che lega tra loro i neofascisti e anche – in misura chiaramente diversa – Calimero e sua sorella. Quanta importanza ha la lingua nella costruzione dei legami che percorrono una storia?
Uno scrittore, alla fine, è la sua lingua. Puoi essere il più grande costruttore di trame, di intrecci, puoi inventarti personaggi maledetti, affascinanti, potenzialmente indimenticabili. Tutti elementi necessari, a seconda dei casi, alla costruzione letteraria. Ma a fare la differenza, poi, sarà il modo in cui tu scegli le parole, le frasi, il ritmo per tradurre in scrittura quelle grandi (o meno grandi) idee. Come lettore, mi innervosisco (o mi appassisco) quando sento uno scollamento tra l’idea dell’autore e il linguaggio che ha usato per metterla sulla pagina.
Come scrittore, cerco di aderire il più possibile con la mia lingua all’energia nascosta che mi muove alla scrittura di quella storia, alle caratteristiche dei personaggi che ho deciso di mettere in scena, al punto di vista che ho scelto in quel preciso momento della narrazione.
Cerco una lingua che sia capace di evocare senza perdere in precisione, di emozionare senza nominare le emozioni. E anche, è vero, di creare essa stessa un rapporto dialettico tra le varie parti, le varie anime del libro. In Nero ananas l’alternarsi di molti punti di vista è stata una bella sfida. Volevo che i vari raggi della ruota, che via via si avvicinavano al punto di contatto finale, i vari personaggi e le varie sottotrame che andavano avanti ciascuna per conto proprio, in qualche modo “si parlassero” anche prima dell’ora X, pur restando autonomi e diversi. Ho provato quindi a diversificare il linguaggio per ogni segmento narrativo, per ogni personaggio, all’interno però di una “lingua madre” che li comprendesse tutti, e restituisse a me per primo e poi sperabilmente al lettore l’idea di essere immerso in un mondo, in un tempo che non c’è più ma che appunto, attraverso i meccanismi dell’evocazione, può tornare in piena presenza.
Dinnanzi a vicende oscure come quelle dello stragismo italiano, la letteratura può aiutarci a capire e giudicare il passato?
Tutto può aiutare, ma, al limite, un romanzo può servire come spunto per ulteriori approfondimenti. È come se volessimo conoscere davvero il momento della crocifissione di Cristo osservando soltanto una pala di Rubens, o di qualsiasi altro pittore ci possa venire in mente. Un romanzo, come un quadro, è comunque la visione di un autore. Anche se si tratta di un romanzo storico accuratamente documentato, l’autore non farà mai un lavoro da vero storico, perché i suoi punti di riferimento, le sue stelle polari, sono, come dicevo prima, la struttura della sua storia, la bellezza (in senso lato) dei suoi personaggi, la forza della sua lingua. La letteratura, certo, in questo come in altri casi può toccare emotivamente le persone che leggono, rendendo vivi nella loro interiorità figure e fatti che altrimenti sarebbero rimasti poco più che nomi. Questo, nei casi più fortunati, può generare nel lettore la curiosità di saperne di più, di andare a leggersi i saggi storici che in modo meno “artistico” raccontano quella porzione di mondo descritta nel romanzo. Che però agisce su un altro piano, si pone altri scopi, rispetto al serrato rispetto delle fonti. Il romanzo punta a generare, nella testa dei lettori, un immaginario che prima non c’era.
L’arricchimento, se c’è, sta lì: nella creazione di qualcosa di assolutamente immateriale. Se poi tutto questo immaginario darà luogo a curiosità, ricerche e approfondimenti ulteriori, sarà uno di quei fortunati casi in cui l’immateriale si trasforma in qualcosa di meno vago: una maggiore consapevolezza storica.
Ma è un di più che non si può chiedere direttamente alla letteratura. Ed è bene che anche lo scrittore non lo chieda a sé stesso: si rischiano romanzi a tesi, racconti didascalici. Da lettore io li evito come la peste. Da scrittore, cerco di non cascarci.
Recensione di Ginevra Amadio
Valerio Aiolli, Nero ananas
Il romanzo di Valerio Aiolli colma una lacuna d’insostenibili proporzioni circa il rapporto, complesso e necessario, tra letteratura e violenza politica degli anni Settanta. Il valore di Nero ananas (Voland, 2019) è riscontrabile già dal titolo, vera e propria epitome di una potenza evocativa che l’autore dispiega a partire da un accostamento inusuale, in realtà sapiente fissazione di due elementi generalmente distinti: l’oppressione della morte e il pulsare della vita. L’ananas del titolo, come noto, si riferisce alla tipologia di bomba a mano utilizzata nella strage di via Fatebenefratelli a Milano con cui Aiolli sceglie di concludere il suo testo. Il richiamo tuttavia inevitabile, quasi inconscio, che tale parola porta con sé – il frutto esotico dai molteplici benefici, tipico di aree tropicali percepite come luminose,vitali – genera un cortocircuito discorsivo e mentale che intercetta le zone dell’immaginario deputate alla costruzioni di miti ormai sedimentati nella memoria.
La compresenza di luce e buio, come ampiamente riconosciuto dalla critica, costituisce uno dei motivi dominanti, finanche ossessivi, della costruzione narrativa sul terrorismo italiano, ma la sua capacità di tenuta è spesso inficiata da debolezze di fondo, strategie prevedibili e chiavi di lettura usurate.
Aiolli, invece, costeggia il terreno rassicurante delle rappresentazioni intimiste e degli schemi del noir per poi addentrarsi in una mescolanza di generi tutt’altro che prevedibile, segnata non dalla tendenza alla rottura dei confini quanto dall’ordinata e cauta direzione stabilita per ogni sezione. La volontà di narrare gli anni che separano la strage di piazza Fontana (12 dicembre 1969) da quella di via Fatebenefratelli (17 maggio 1973) attraverso un racconto ibrido e dalle molteplici focalizzazioni risponde al bisogno di ribadire che non vi è, in letteratura, un accesso diretto alla comprensione della storia, né questa può avere la presunzione di trovare la verità. Le porte lasciate aperte, i rovelli interiori che sfiorano il campo della dimensione comune – quella della “perdita dell’innocenza” del paese –, e il margine di incertezza insito in tutte le cose contribuiscono da loro, nella resa narrativa, a tracciare un quadro di ombre inquietanti di cui si avvertono gli effetti ancora oggi. A confermare la peculiarità di Nero ananas concorre tra l’altro la decisione di mettere in bocca al personaggio più ambiguo del testo il rimando inconsapevole alla metafora del buio, col suo significato di accecamento mentale e di anestesia etica:
«Bomba ananas. Ti piace l’unione di questi due termini. Ti dà la sensazione di tenere in mano qualcosa di vivo. O qualcosa che è stato vivo. Un ponte tra la vita e la morte».
Gianfranco Bertoli, lo pseudo anarchico autore della strage alla Questura di Milano, è il carattere in cui meglio s’incarna la sospensione della coscienza e della storia – l’individuo di carta che riassume i misteri, gli omissis, i buchi neri di quella stagione.
La sua vicenda è narrata da Aiolli in seconda persona, e tale espediente gli consente uno scavo interiore che – a differenza di quanto avviene con gli altri attori in gioco – annulla ogni possibile filtro tra i lettori e l’azione. È questo un altro grande merito dell’opera, completamente scevra da quella sorta di pudicizia che vizia altri romanzi sul tema, caratterizzati da una rappresentazione sfumata della violenza o da un racconto esemplato sul modello della comunicazione di massa. L’operazione che compie Aiolli rientra invece nelle competenze del grande narratore, il quale sa sfruttare le potenzialità del linguaggio per rivelare i pensieri dei personaggi e mostrare i meccanismi che li spingono ad agire. Il suo è un lavoro in cui la documentazione si accompagna allo scandaglio interiore, rivelando sotto il piano della rievocazione storico-politica una precisa fascinazione per le contraddizioni dell’individuo. I binari lungo cui si muove la storia procedono separati ma s’intersecano – ancor prima dell’effettiva convergenza finale – proprio nella continua integrazione tra “politico” e “privato”. In questo senso, l’immaginaria vicenda di Calimero costituisce il veicolo attraverso il quale sovrapporre i due piani, con gli eventi scanditi dallo sguardo ingenuo ma via via sempre più vigile del ragazzino, segnato dalla perdita della sorella fuggita per darsi a una misteriosa clandestinità.
Qui la raffinatezza del racconto si arricchisce di suggestioni letterarie che riportano alla mente una delle prime prove sul tema, quel Caro Michele di Natalia Ginzburg di cui si avverte il senso di spaesamento e gelo.
Come congedandosi da un ricordo lontano, Calimero e la sua famiglia disperdono, con la scomparsa della sorella, il tepore di un’unione in cui era possibile riconoscersi, segnata – come la Ginzburg insegna – da un codice comune di comportamento, da un linguaggio capace di trasmettere messaggi anche «nel buio di una grotta».
Nel loro ultimo incontro Calimero e la giovane si abbracciano ma hanno quasi, per un lungo tempo, le labbra serrate. «Cercavo di tracciare traiettorie, di indovinare confini. Di scovare punti di contatto. Avevo sperato di rivedere una parte di me, invece mi stavo ritrovando a cercare di stabilire un linguaggio comune con un’estranea». La bomba, già deflagrata e destinata a scoppiare, di lì a poco, per altre infinite e drammatiche volte, ha generato un’esplosione più silenziosa di quella dello squarcio, disperdendo unioni, sogni, utopie. Accanto alla storia dei neofascisti dai nomi parlanti e dei politici divorati dall’ambizione sta dunque un racconto intimo che non conduce ad assoluzione, e in cui il topos familiare conflagra nella difficoltà di una comprensione plausibile. Con una lingua capace di picchi intensissimi e uno stile asciutto ed evocativo, Valerio Aiolli restituisce alla letteratura quell’intensità di sguardo avversa a qualsiasi edulcorazione della realtà. Dal fondo di Nero ananas si esce senza certezze, ma è un peso di cui la narrativa non può farsi carico quello di pretendere il possesso totale di una realtà sfuggente. L’autore fiorentino lo sa, e l’ha messo in atto. Di un’opera così se ne sentiva davvero il bisogno.