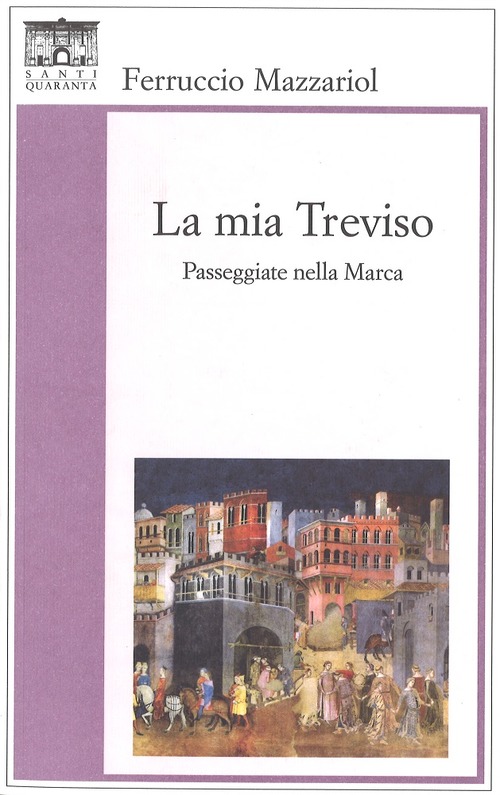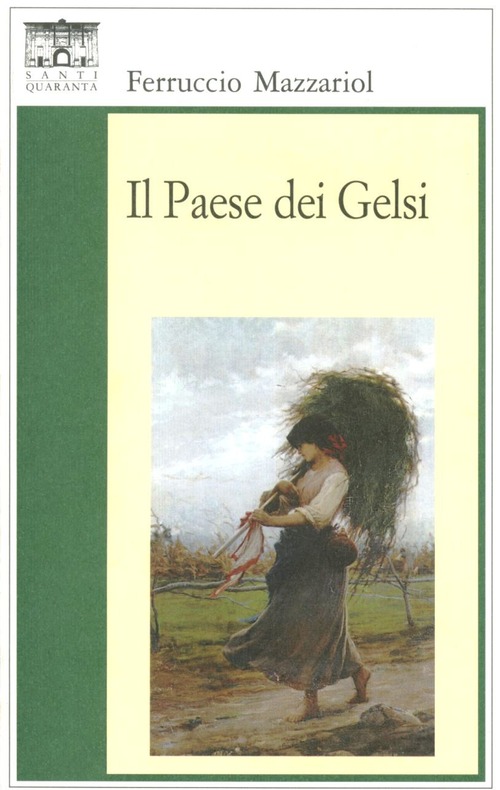Pangea, Posted On Marzo 16, 2019
“La mia è stata un’infanzia piena di gioia, meravigliosa; in essa hanno posto radici i miei angeli, tutta la mia vita. Ringrazio Iddio”.
Queste tra le prime parole con cui si apre Il paese dei gelsi di Ferruccio Mazzariol, uomo e già bambino fortunatissimo per la sua infanzia felice in un Veneto altrettanto tale, come recita il celebre titolo di un volume di scritti comissiani, dunque in un tempo e in un luogo nei quali poté subito accorgersi che “la vita aveva un destino eterno, non si sarebbe persa come un ciottolo nelle Grave”.
Non tanto di fortuna si trattò insomma, bensì d’eredità e fede – d’eredità della fede, e non è un caso che Charles Péguy e Georges Bernanos siano tra gli autori da lui più amati – dunque storia, e con essa la vita, che precede e procede e mai non cede, tramandata di padre in figlio come egli stesso si è premurato di fare con
La mia Treviso, città che dice anch’essa, come la vita nella fede, appartenergli sin da quand’era soltanto un bimbo, ed “entrata a poco a poco nel cuore come avviene per gli innamoramenti che durano”.
Quello natale di Mazzariol è un paese di gelsi e vigne, dono del Signore e delle opere degli avi, i cui frutti a Dio sempre riconsegnarono in forma d’amore per Lui e per la terra che fu loro data in dono forse più che in pegno,
e infatti “i pontepiavesi che muoiono portano il loro paese di gelsi e vigne al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo”, perché terra la cui economia popolare dei bozzoli e gli esordi industriali delle filande e dei setifici si fondava sui “cavalieri”, ovvero i bachi, portati via Bisanzio in Veneto e in Lombardia da alcuni missionari di ritorno dalla Cina, durante le Crociate, regalo dunque di due sante spedizioni (poiché niente è per caso), che sulle lucide foglie dei gelsi affiancarono l’uva in quelle “terre di vetusto impianto, colme di sassi cesellati dalle piene”, ronchiate nei secoli dalle stirpi di cimbre e celtiche che, dopo il lungo stato di grazia della Serenissima, ebbero la buona sorte di vivere sotto i vessilli degli Asburgo – cui l’autore trevigiano ha dedicato una terzo, leggiadro e accoratissimo libro, Le aquile bianche dell’Imperatore – e ne fecero un giardino incantato in cui gli acini, disgraziatamente – ringraziando la Filossera vastatrix importata, come troppe altre piaghe dagli Stati Uniti d’America via la Francia – in molti casi non autoctoni, come
il Cabernet e il Merlot, assorbono gli “umori fragranti” del limo della Piave che nutre però anche il Prosecco, il Verduzzo e soprattutto il Raboso, “nero come la pece, adatto per palati solidi di forte carattere”, come scrive Mazzariol, “un vino poderoso adatto per il palato degli arcangeli guerrieri”.
*
Mazzariol… Nato ottant’anni fa, il 16 marzo 1939 in località Ponte di Piave – frazione Alle Grasseghelle, e vale a dire presso il “colmello” della Grasseghella – sulla riva del Piave, anzi, come ricorda, della Piave, femminile – e ben diversi suonano alle orecchie “il Piave mormorava” e “la Piave mormorava” – come da queste parti sempre la gente ha chiamato il suo fiume – che è allora, con l’Adda che taglia la Lombardia, l’unico “italiano” non maschile – che è, nelle parole di Comisso, la “grande vena di questa terra”…
Mazzariol… Scrittore ma anche traduttore dal francese (sue le versioni in lingua italiana del romanzo La donna povera di Léon Bloy e del volume di Lettere e diari di Emmanuel Mounier per la casa editrice La Città Armoniosa) nonché editore (col marchio doppiamente “di culto” Santi Quaranta, da una delle porte di Treviso, già nome della vicina chiesa oggi di Sant’Agnese, in direzione di Padova e Vicenza, alla fine di quello che è ora squallidamente detto Borgo Cavour) nella sua Treviso; che così descrive:
“Città socievole, espansiva; patrizia e graziosa e insieme alla mano, mi ha affascinato prima di tutto per il dialetto amabile che sa di risorgiva fresca; un dialetto discreto e canterino che era una meraviglia in bocca alle donne e alle ragazze, e che ora purtroppo sta decadendo”.
Eppure, “dove Sile a Cagnan s’accompagna” (Dante, Paradiso, IX, 49) il dialetto trevigiano è ancora incantevole, melodico, femminile (già, come il nome Piave) nelle bocche degli uomini come in quelle delle donne, come annota Guido Piovene nel suo Viaggio in Italia, e resiste, e conserva così la peculiarità legata ai suoi corsi d’acqua, perché, scrive Mazzariol,
“l’idioma trevisano continuava il mormorio del Buranello, del Siletto, del Cagnan; traduceva in parola armoniosa e cantabile il pullulare delle fresche risorgive”.
Come tutte le città padane e venete, e antiteticamente a Venezia che è terra nel mare, Treviso è isola ideale sulla terraferma, forgiata non dalle onde sugli arenili ma dal gesto delle mani degli uomini, col Botteniga che presso il Ponte della Pria si divide in tre, il Buranello, il Siletto e il Cagnan.
“Si tratta di una dolce foresta mossa dal vento delle abitudini e della vita. L’indole recita, appare ma possiede un suo radicamento ancestrale che distingue” i trevigiani,
non solo nelle aree rurali della Marca, ma anche in quella urbana, questo teatro di dolci finzioni, seduzioni, relazioni. Con l’acqua a informare col suo altrettanto dolce scorrere tra gli antichi muri l’attitudine che Mazzariol così riesce a riassume:
“Non mi logoro per niente; lascio passare l’acqua sotto i ponti placida mente. No me susto par poco, cioè non vale la pena guastarsi il sangue per delle inezie.” Acqua dolce e così la vita.
*
Non mi affliggo per poco. È il motto di quest’indole dolce, garbata, delicata, savia, allegra, socievole e sorniona a un tempo, scrive Mazzariol, non esattamente disimpegnata anche se tale è l’aria, in realtà più che altro noncurante;
che fa quella splendida devise che la riflette, nutrita da “un pizzico di fatuità, una soave vanità”, che si esibisce alquanto, e che mantiene una certa qual “riserva mentale, eccessiva diplomazia” che non rende tuttavia cinico il trevigiano che ha cuore “caramelloso però gradevole e pronto spesso alla generosità”, così come l’altro motto cittadino, No vao a combatar, ben lungi da essere un segno d’inazione, specie negli ultimi decenni di rapida industrializzazione, dice di una forma d’indolenza del tutto atipica, anche perché, come rimarca Mazzariol, “fosse una caratteristica totalmente negativa, i trevisani non avrebbero potuto edificare una città così bella e così graziosa”, la cui grazia urbanistica non è che il riflesso di tale attitudine, l’una e l’altra capaci di resistere alle devastazioni del risorgimento, con tutti i suoi strascichi, e delle due tragiche guerre mondiali.
Il No vao a combatar è la sorda resistenza estetica e morale della Marca, che vive sottotraccia negli stravolgimenti storici, sotto l’occupazione napoleonica – “le orde del Napoleone, fameliche e feroci”,
così le descrive Mazzariol, che chiaramente e giustamente le detesta – come sotto quella, successiva, degli italici, con i francesi che saccheggiarono la sua città, predando, dissacrando, rovinando il possibile, e i secondi che trasformarono la regione da teatro di vita a teatro di morte, mentre sotto gli Asburgo nella Marca persino i bachi prosperavano, tutelati come persone dal diritto penale, per volontà dello stesso Francesco Giuseppe.
A queste nefandezze Mazzariol oppone il suo Duca Alfonso, sempre presente nei secoli e nella storia, spesso controcorrente, anche perché poeta, attivo per il bene della sua città, fautore di una congiura contadina, nel 1812, che porterà alla definitiva caduta di Napoleone e quindi agli Asburgo, tanto da esser nominato luogotenente per la Sinistra Piave, che governa con saggezza e misericordia cristiane, migliorando le condizioni della gente, perché tutti possono pescare e cacciare, portare le bestie ai pascoli, e, grazie a una dieta molto più ricca, è così infine vinta la pellagra.
*
A Salgareda, il Duca arriva a mettere a disposizione dei nullatenenti alcuni suoi campi, che diventano La Comun, poi El Comun, che il nonno di Mazzariol acquisterà con l’avvento degli italici, ultimo grande gesto del Duca Alfonso in cui il libro di Mazzariol tutta la storia della sua città si cristallizzano, questa figura di nobiluomo della Piave che abita nel suo castello Delle Grasseghelle, eroe dal “cattolicesimo umanissimo” che “picchia i furfanti, tramortisce i ladri con la sua alabarda ruspia; ingaggia duello con i vari Don Rodrigo dei diversi paesi che stanno prossimi a Trevigi e sempre li sconfigge”, e che è romanticamente preso d’amore per la bella Maria Beatrice Della Galea.
Si fidanzano e il Duca fa costruire, affrescare e decorare la Loggia dei Cavalieri. Loggia che l’autore dice “austera, romantica”. Un ossimoro perfetto per tutta la sua Treviso.
Tale è d’altro canto lo stesso Duca Alfonso… In lui è tutto l’ideale realizzato della città di Mazzariol, nel suo eterno ritorno, dal 1177 fino a oggi, con aggraziata costanza. E lui e Treviso sono simbolo di un mondo antico, storico e mitico a un tempo, e cortese nel senso dei troubadour provenzali…
Molti di essi si stabilirono in città, ma stando a Mazzariol anche lo stesso Duca si dilettò in questo ambito come in tutti gli altri, “benché nessuno storico erudito lo menzioni”.
Il Duca Alfonso non solo scrive versi, ma anche memorie. Ama leggere, ma anche andare a cavallo per le campagne. A volte con la sua bella consorte, altre in totale solitudine. Monta un sauro bianco e girovaga sui colli, pacifici finché non irruppe Napoleone con le sue truppe, tra i filari di Raboso, lungo la Livenza e fino alle sue sorgenti, alla basilica della Santissima Trinità, luogo del suo ritiro durante le due guerre mondiali e la sciagura fascista, “poco gradita ad Alfonso per quel suo sempre parlare coi gambali e la camicia nera di battaglie, violenze agli altri popoli, olio di ricino somministrato agli avversari politici”. Treviso è neutralista, avversa a una guerra che è inutile strage. Troppo stride col motto No vao a combatar dei trevigiani. E i sudditi degli Asburgo sono ben più fratelli degli italici. Perché gli italici sono accecati dal mostro del nazionalismo.
Se enorme era la stima dei trevigiani e dei veneti tutti per gli austro-ungarici, mai sarà tale invece per la “classe […] esistenziale, militante, squadrista” dei fascisti, con i suoi miti posticci, né tantomeno per il nazismo, per il comunismo o per gli americani. Due guerre. Liberazione. Dopoguerra.
Veneto libero? No. Veneto felice? Sì. Perché ha san Marco e può far San Marco, festa “cristiana e delicata”, festa “ancestrale e serena”.
Marco Settimini